John Holt individua ben sette buoni motivi per cui “non correggere gli errori è la cosa giusta da fare”¹.
Alcuni di questi sono legati al rispetto verso la persona che vorremmo aiutare: se lo stesso errore d’italiano fosse commesso, al esempio, dal direttore americano della multinazionale per cui lavoriamo, lo correggeremmo allo stesso modo? I bambini sono persone in formazione, con una sensibilità elevata, un’autostima fragile e una struttura psichica non matura.
Altri di questi motivi sono la conseguenza logica dell’inefficacia dell’insegnamento non richiesto e del giudizio. Se è vero che insegnare senza aver ricevuto l’invito a farlo è antipedagogico, se è certo che il giudizio è dannoso, a maggior ragione la correzione è inappropriata, sottolinea l’atteggiamento giudicante, mette in luce il fallimento di un tentativo di scoperta, è frustrante e quindi inibisce il processo di apprendimento.
Altri motivi derivano dalla natura di ciò che consideriamo errori. Essi infatti corrispondono a una fase di elaborazione tipica della scoperta e dell’esplorazione che caratterizzano l’apprendimento spontaneo: il bambino fa un’ipotesi che gli pare plausibile per spiegare un determinato meccanismo (ad esempio, vuole aprire un cassetto chiuso a chiave); fa un tentativo (tira il cassetto senza girare la chiave) e valuta poi cosa succede. Se le sue previsioni si rivelano false, ne formula altre e sottopone anche queste a un test. Fino a quando non trova la soluzione. E allora wow! Lo vediamo raggiante: ce l’ha fatta!
Correggendo trasmettiamo un messaggio negativo, del tipo: lo vedi che senza di me non ce la fai? Il bambino perderà lo stimolo a riformulare le sue ipotesi e a giungere a nuove deduzioni: il suo spirito di iniziativa, la sua capacità di adattamento dei propri comportamenti all’ambiente verranno penalizzati. Se invece non correggiamo l’errore ma ci limitiamo, semmai, ad esprimere la nostra gioia o a condividere la sua soddisfazione per il risultato ottenuto (ad esempio, con un a frase del tipo grazie per averlo aperto), rinforziamo l’autostima e diamo un input alla sua riflessione.
La capacità analitica, l’intraprendenza, la flessibilità, la capacità di formulare strategie e di modificarle in base alla loro reale efficacia, la fantasia e il coraggio di esperimentare, l’autonomia decisionale e di scelta, sottese a tali attività sono tutte operazioni cognitive di alto valore, che, se acquisite e sviluppate fin dalla tenera età, vanno a potenziare le funzioni esecutive, così necessarie ad una crescita personale a tutto tondo.
Gli errori, quindi, non vanno corretti, sottolineati, né tantomeno puniti, ma considerati per quello che sono: una fase necessaria dell’apprendimento, nella quale il bambino o il ragazzo si mette in gioco a 360° e si arrischia a fare delle prove.
C’è tutta una fase della vita del bambino in cui quest’ultimo impara in modo quasi inconsapevole, esattamente allo stesso modo in cui respira. Impara imitando, giocando, esperimentando, semplicemente vivendo. Il fatto di correggerlo rischierebbe di renderlo consapevole del processo che è in atto spontaneamente in lui, se non addirittura di bloccarlo. Tale modo “adulto” di inserirsi arbitrariamente nell’apprendimento può confondere il bambino e disturbare il suo sviluppo. Inoltre, ognuno di noi impara meglio e ricorda più a lungo ciò che ha esperimentato, scoperto o dedotto da sé piuttosto che ciò che gli è stato insegnato. Non solo, ma il bambino, “tutte le volte che scopre qualcosa, aumenta la fiducia nella propria capacità di scoprire le cose”.
Conclusa questa fase di apprendimento quasi inconsapevole, inizia quella in cui i ragazzi imparano per un atto di volontà. Ma da ciò “non consegue che vogliano che glielo si dica. Un bambino sano preferirà scoprire quasi sempre le cose da sé”, insegna John Holt.
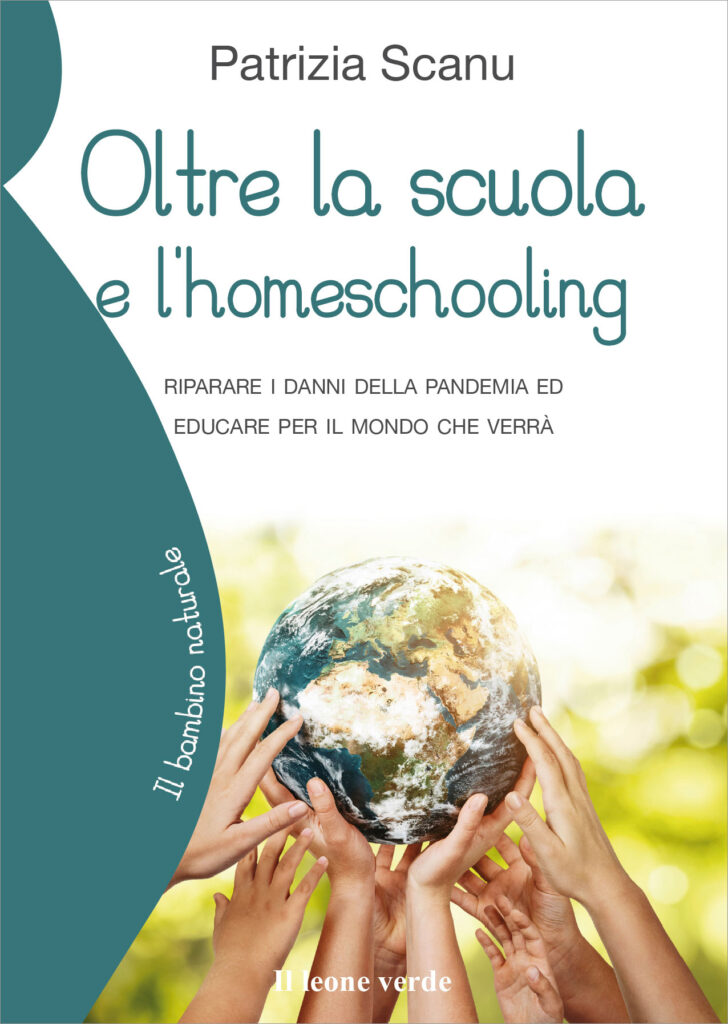
Oltre la scuola e l’homeschooling
Riparare i danni della pandemia ed educare per il mondo che verrà
Una proposta di intervento educativo da realizzare nel contesto dell’istruzione parentale per gli allievi della scuola secondaria inferiore e superiore, ispirata al modello umanistico dell’educazione integrale (che coinvolge corpo, mente, anima e spirito), con il proposito di formare anime libere e capaci di sentire e di pensare.
di Nunzia Vezzola
Docente di scuola superiore e socia fondatrice dell’Associazione Istruzione Famigliare – www.laifitalia.it.
¹ Le citazioni sono tratte da: John Holt, Learning all the time, Da Capo Edizioni, 1989, pp. 137-139.




